La TSGN poggia su tre principi fondamentali che sono:
a) la selezione dei gruppi neurali;
b) il rientro;
c) la mappa globale.
Questi tre principi riguardano l'organizzazione iniziale dell'autonomia del cervello durante lo sviluppo, la successiva distinzione di tracce di risposta nel corso dell'esperienza e il rientro, quale processo di scambio di segnali fra le mappe cerebrali così costituite, che dà origine a funzioni importanti dal punto di vista del comportamento.

Secondo il primo principio, i processi dinamici primari di sviluppo portano alla formazione delle caratteristiche neuroanatomiche di una data specie. I livelli e le ramificazioni più sottili di questa anatomia sono, necessariamente, di un'estrema variabilità.
Le cause sono molteplici: in primo luogo la regolazione dinamica delle CAM (molecole di adesione al substrato) e delle SAM (molecole di adesione fra le cellule), la variabilità stocastica dei movimenti, l'estensione dei prolungamenti e la morte delle cellule durante lo sviluppo; in secondo luogo l'accoppiamento, dipendente dall'attività delle connessioni, imposto alla rete dei neuroni nella fase in cui esplorano una regione cerebrale in sviluppo. Occorre sottolineare come l'intero processo si basi sulla selezione e coinvolga popolazioni di neuroni impegnate in una competizione topobiologica.
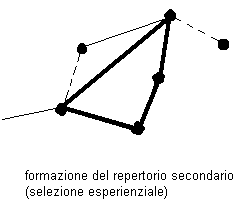
Si definisce repertorio primario un insieme variabile di gruppi di neuroni in una data regione del cervello, incluse le reti neuronali che emergono attraverso processi di selezione somatica. Il codice genetico non fornisce uno schema preciso e dettagliato per arrivare alla formazione di questi repertori, ma piuttosto impone un insieme di vincoli al processo di selezione.
È improbabile, cioè, che individui geneticamente identici abbiano circuiti identici, anche in presenza di questi vincoli, poiché la selezione
è epigenetica e dipende sostanzialmente dalle esperienze condotte.
Il secondo principio illustra un altro meccanismo di selezione che,
in generale, non implica mutamenti delle configurazioni anatomiche: si suppone che nel corso delle esperienze di comportamento,
specifici processi biochimici rafforzino o indeboliscano in modo selettivo le connessioni sinaptiche.
Questo meccanismo, che sta alla base della memoria e di un certo numero di altre funzioni, ritaglia effettivamente dalla rete anatomica,
mediante la selezione, una varietà di circuiti attivi.
Questo insieme di circuiti funzionali varianti si chiama
repertorio secondario. In una certa misura, i meccanismi che conducono alla formazione dei repertori
primari e secondari s'intrecciano tra loro. A volte, in alcune aree, la formazione di un repertorio primario dipende dalle
modifiche nella forza delle connessioni sinaptiche.